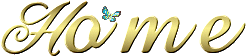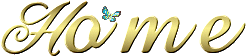LE GUERRE

Il Quattrocento fu un secolo di grandi trasformazioni politiche,
realizzate attraverso guerre devastanti che spinsero
gli inventori alla ricerca e all’innovazione.
Verso la fine del XV secolo i montanari svizzeri inventarono la fanteria pesante
che prendeva spunto dalla falange macedone.
I loro fanti non si limitavano a difendersi dalle cariche della cavalleria,
ma andavano all’attacco
contrapponendo, alla forza d’urto dei cavalieri corazzati,
quella di uno o più quadrati di migliaia di fanti.
Essi, schierati in 70 file di 85 uomini l’una, armati di picche lunghe sei metri,
prima fermavano e scompaginavano la cavalleria, poi avanzavano
lentamente ed ordinatamente travolgendo ogni ostacolo.

La prima prova del loro valore, gli Svizzeri la diedero il 15 novembre 1315
sui campi di Morgarten, dove 1.300 pastori delle Alpi (dei Cantoni di Uri, Schwitz, Unterwald),
semplicemente vestiti di lana, respinsero l’attacco di 8.000 fanti e 4.000
cavalieri austriaci corazzati,
uccidendo 1.500 nemici (gli Svizzeri ebbero solo 14 perdite).
Da allora fino al 1477, sconfissero: Austriaci, Francesi e Borgognoni
e acquistarono una fama sempre maggiore che li fece diventare preziosi per tutti gli Stati,
(Ancora oggi le guardie del Papa sono reclutate esclusivamente nel Paese alpino).
Seguirono l’esempio degli Svizzeri, i fanti lancieri germanici di Massimiliano I,
i cosiddetti Lanzichenecchi che commettevano violenti saccheggi
e portarono la peste e i Tercios Spagnoli.
Questi ultimi, base degli eserciti di Filippo II, rappresentarono
il massimo prodotto dell’evoluzione militare europea del Cinquecento:
potevano sviluppare la potenza di fuoco degli archibugi,
proteggersi con un’impenetrabile cintura di picche,
passare rapidamente e disciplinatamente dalla difesa all’attacco.
Il «tercio» comprendeva 3.000 fanti, tra archibugieri e picchieri,
un distaccamento di cavalleria leggera e alcuni pezzi d’artiglieria.

Sul campo di battaglia si presentavano come un solido baluardo di picche guarnito da archibugi,
torrioni e contrafforti laterali di moschettieri pronti a ripiegare al riparo delle armi bianche.
Ma i militari di prima qualità furono i giannizzeri turchi (dal turco «yeni çeri», cioè «nuova milizia»):
disciplinati, ubbidienti, coraggiosi, spietati, costituirono il nerbo del potente esercito ottomano;
non temevano la morte, anzi la ritenevano, in battaglia, una fine gloriosa.

Istituiti dal Sultano Orkhān nel 1329, le prime unità dei Giannizzeri
comprendevano prigionieri di guerra e schiavi.
Dopo il 1380, il sultano Mehmet I riempì le loro fila con il devşirme
(raccolta).
I funzionari del sultano selezionavano un certo numero di ragazzi, di età compresa
fra i 7 e 14 anni, in genere cristiani abitanti nei confini dell’Impero Ottomano
(di preferenza albanesi, bulgari e bosniaci), che venivano convertiti
con la forza all’Islam e istruiti ad una fanatica osservanza religiosa.
Ai Giannizzeri veniva insegnato a considerare il corpo come la loro casa,
ed il reggimento come la loro famiglia, mentre il sultano era il loro padre.
Ma, solo quelli che dimostravano il proprio valore, accedevano al vero titolo
di giannizzero intorno ai 24 o 25 anni.
Il corpo dei Giannizzeri aveva molti aspetti particolari.
Essi indossavano uniformi, erano pagati con monete come le truppe regolari
e marciavano al suono della musica del mehter, una banda militare.
Inizialmente il loro numero era di 6.000 unità, poi furono portati a 60.000
e in certi periodi raggiunsero le 100.000 unità.
Gli averi dei soldati morti venivano ereditati dal reggimento.
Fu un tempo duro dove non esisteva né il sentimento dell’onore, né di pietà.
Spesse volte le città che si arrendevano venivano rase al suolo, i prigionieri massacrati.

Gli eserciti non avevano medici; solo il Signore si portava dietro quello suo
personale
che,
naturalmente, prestava le prime cure a lui e poi ai suoi amici.
I feriti venivano lasciati sul campo o medicati con tale ignoranza
che la maggior parte
moriva dissanguata o per infezione.
I nemici feriti venivano abbandonati e solo in casi rarissimi raccolti.
Il sistema più in uso per curare le ferite era la cauterizzazione:
cioè le si bruciava con un ferro rovente.
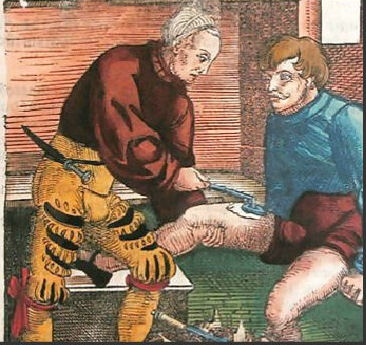
Questo sistema fu studiato intorno alla fine del X
e all’inizio dell’ XI secolo dal chirurgo Abul Casis, che ne parla nel suo Kitab al Tasrif.
Era un sistema barbaro, perchè la cauterizzazione veniva effettuata
senza altro anestetico che il vino oppiato.
Solo dopo il 1545 verrà pubblicato un libro di Ambroise Paré sulle ferite degli archibugi
e sulla loro cura: a partire da quell’anno, molte vite furono salvate
e il ferro rovente venne a poco a poco abbandonato.
Ambroise Paré può essere definito il "padre della Chirurgia> moderna".
.
Figura di grande spessore nella Francia e nell'Europa del secolo XVI,
fu il chirurgo di grandi sovrani francesi, quali Enrico II, Francesco II, Carlo IX ed Enrico III.
Ma fu sul campo di battaglia che divenne famoso e conosciuto in tutta Europa.
Egli infatti, nel 1537, accompagnando il duca di Montejean, si trovò a prendersi cura
dei soldati feriti durante la battaglia del Passo di Susa.
In quel tempo le ferite venivano curate con dell'olio bollente ed un ferro arroventato per cauterizzare.
Un giorno, però, a corto di scorte, Paré ideò un'alternativa alle cure tradizionali, mescolando
rosso d'uovo, olio di rose e trementina ed ottenendo un disinfettante migliore di quello utilizzato,
poiché questo non produceva effetti devastanti come il precedente.
Facendo ciò egli corse un grosso rischio, dato che avrebbe potuto perdere il posto
o addirittura essere punito con la vita.
Così egli ricordò l'avvenimento:
"La notte non riuscii a dormire tranquillo, col timore, per la mancata cauterizzazione,
di trovare morti avvelenati coloro con i quali non avevo usato l'olio bollente;
pertanto mi alzai molto presto per visitarli, e, con mia grande sorpresa,
scoprii che quelli ai quali avevo applicato la lozione medicinale non soffrivano molto
e le loro ferite non presentavano infiammazione e gonfiore, e la notte avevano riposato
ragionevolmente bene; gli altri, su cui avevo usato il detto olio bollente, li trovai febbricitanti,
in preda a forte dolore e con gonfiore intorno alle ferite.
Allora decisi tra me che mai più avrei crudelmente bruciato dei poveretti feriti con armi da fuoco".
Ambroise Paré, Journey in diverse places

Egli elaborò anche una tecnica di legatura delle vene che sperimentò durante l'assedio di Danvilliers,
quando si trovò a praticare un'amputazione ad uno degli stretti collaboratori del Conte di Rohane.
Fu in questa occasione che Paré, invece di cauterizzare la ferita con il ferro rovente,
utilizzò per la prima volta la sua tecnica di legatura dei vasi, riuscendo a salvare il paziente.

E' in questo periodo che cominciarono ad affermarsi sempre di più le armi da fuoco.
Già nel Trecento l’uso e il perfezionamento della balestra, molto più micidiale dell’arco
e capace di perforare le corazze dei cavalieri, aveva rivoluzionato le tecniche di combattimento,

ma l’evoluzione più radicale fu determinata dall’invenzione delle armi da fuoco.
La polvere da sparo era già stata scoperta nel X secolo dai Cinesi
che la usavano soprattutto per fare i fuochi artificiali.
Quando gli Europei ne vennero in possesso, pensarono subito di impiegarla
per lanciare proiettili di pietra a grande velocità e a grande distanza.

Dopo una serie di tentativi andati a vuoto, verso la fine del Trecento.
fu inventato il cannone, realizzato dai fonditori di bronzo costruttori di campane.
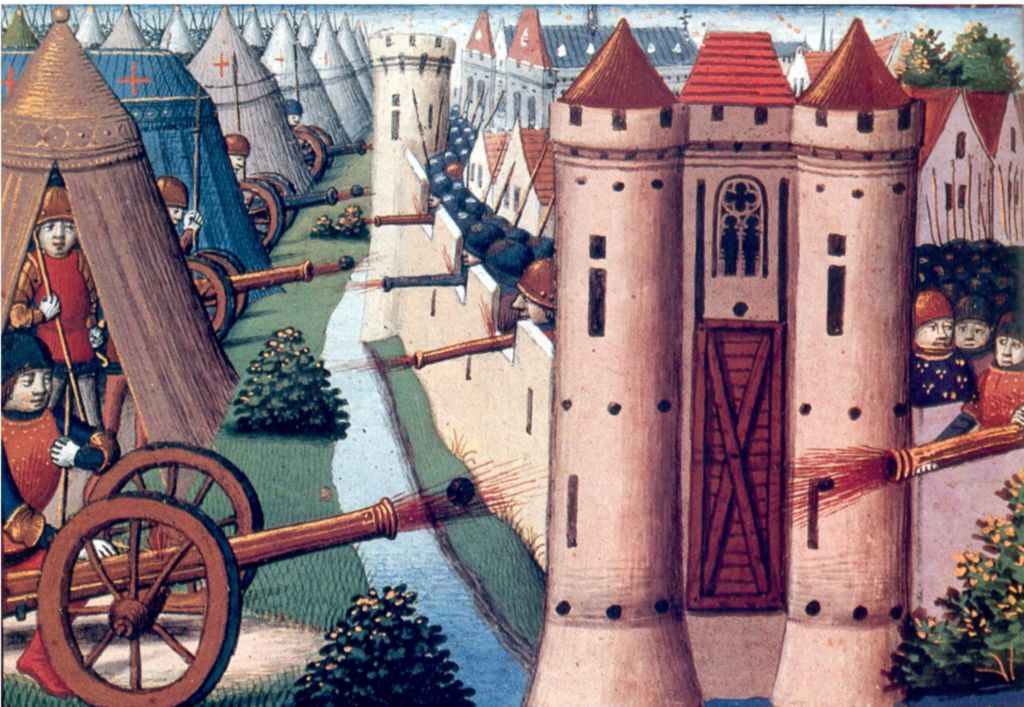
L'origine del cannone con tutta probabilità è orientale.
Tuttavia, i primi pezzi d'artiglieria erano difficilmente manovrabili,
erano pesantissimi e spostarli attraverso i campi di battaglia
dell'Europa era certamente difficoltoso.
Questo il motivo per il quale venivano usati poco.
Bisognò attendere sino al Quattrocento per vedere la comparsa
di migliori tecniche di puntamento, migliori tecniche di carica e di accensione
e aumentata manovrabilità, con l'introduzione delle ruote al cannone.
Così il cannone e i suoi più stretti parenti (colubrina, mortaio, bombarda,
falconetto, etc.)
divennero i protagonisti della scena bellica.
Il cannone fu poi seguito dal moschetto, usato dalla fanteria,

la pistola usata dai cavalieri e la mina, una miscela di polvere da sparo
collegata con una miccia, in grado di far crollare le mura dei castelli.
Fu proprio l’uso progressivo delle armi da fuoco che fece decadere
le fortificazioni e il castello in particolare.
Esse, inoltre, aumentarono a dismisura il numero dei morti.


In campo aperto, l'artiglieria scaricava sui cavalieri e sui fanti un mare di fuoco,
mentre le fortificazioni si sgretolavano.
Ormai il castello non era più in grado di proteggere il signore dagli attacchi del nemico
e questo determinò il declino dell'intera concezione delle fortificazioni,
venne riconosciuta l'inadeguatezza delle alte torri, dei merli e delle mura sottili.
Le fortezze si ampliarono, lo spessore delle mura divenne imponente,
mentre le fortificazioni vennero sostenute da terrapieni e bastioni.
Anche Niccolò Machiavelli si interessò dell'arte bellica,
e affidò le sue idee a un famoso testo dal titolo, appunto, L'arte della guerra (1521).

Si tratta del primo testo teorico dell’arte militare.
E' un trattato a forma di dialogo dedicato a Lorenzo di Filippo Strozzi,
esponente di spicco della vita cittadina di Firenze.
È suddiviso in sette libri, nei quali un famoso condottiero dell’esercito spagnolo,
Fabrizio Colonna (lo stesso Machiavelli), dialoga con vari interlocutori:
Zanobi Buondelmonti, Cosimo Rucellai (a entrambi erano dedicati i Discorsi),
Battista della Palla e Luigi Alemanni.
Come nei Discorsi, Machiavelli prende a esempio la storia dell’antica Roma,
il cui insegnamento deve essere assunto a modello anche nell’arte militare.
Egli affermava che l’organizzazione e la disciplina delle legioni nascevano
dalla forte identificazione dei soldati-cittadini con lo Stato.
Le truppe mercenarie invece, non erano capaci di altrettanta disciplina:
erano insubordinate e anarchiche, perché agivano per ragioni egoistiche,
dunque non erano affidabili né militarmente né politicamente.
La crisi degli Stati della penisola dipendeva appunto, dal ricorso a tali milizie,
che facevano della guerra un mestiere.
Lo Stato può essere militarmente forte solo se è capace di coinvolgere
i cittadini
sul piano politico come su quello militare.
Deve dunque fondarsi sull’arruolamento dei cittadini o dei sudditi.
Machiavelli sottolineava inoltre, l’importanza della fanteria contro l’opinione tradizionale
della superiorità della cavalleria formata dalla nobiltà ormai in decadenza.
Il testo, che ebbe vasta diffusione in Europa, sosteneva la necessità che il soldato
svestisse le vesti del mercenario per indossare quelle del cittadino - soldato.
Un passo avanti verso l'idea di un esercito nazionale
condicio sine qua non di uno stato moderno.
La guerra moderna cominciava così a mostrare il suo vero volto.
In Europa, nazioni come Francia e Spagna erano le uniche in grado di muovere
eserciti numerosi e disporre di cifre considerevoli per le spese necessarie
(costi d'acquisto e costruzione dei pezzi, della polvere da sparo, dei proiettili,
per l'artiglieria
oltre alle ingenti spese per provvedere al trasporto).
I piccoli o medi Stati non potevano che constatare la loro debolezza,
in quanto le alte e solide mura dell'epoca medievale,
ora si sbriciolavano di fronte alle bocche da fuoco dei cannoni, alle bombarde
e alle altre innumerevoli diavolerie dell'industria bellica.

Alla fine del Quattrocento i cannoni avevano sostituito le palle di pietra con quelle di ferro,
potevamo essere spostati su fusti muniti di ruote e trainati da buoi o cavalli.
La tecnica balistica si serviva del contributo di vari esperti:
gli artificieri calcolavano il rapporto fra l'alzo del cannone, la traiettoria
e la potenza del proiettile; i fabbri non avevano tregua nel tentativo di trovare leghe
più resistenti, mentre venivano inventati strumenti da fuoco più piccoli e maneggevoli.
Nacquero così, uno dopo l'altro, in un lasso di tempo relativamente breve,
gli archibugi e i moschetti e seguirono, a breve distanza, le pistole.
Inizialmente si trattava di armi lunghe, pesanti e quindi poco maneggevoli,
che dovevano essere supportate da una forcella piantata nel terreno.

La polvere che sparava il proiettile era innescata dall'accensione di una miccia.
L'intera operazione di caricamento, di puntamento e sparo era lenta, così solo
chi
era in grado
di schierare diversi reparti di archibugieri, poteva superare l'avversario.
Se a Crecy e ad Anzincourt, nel XIV secolo, la cavalleria francese,
la migliore e la più agguerrita d'Europa, si era trovata a mal partito
di fronte agli arcieri inglesi, ora la stessa arma si mostrava del tutto
inadeguata
ad affrontare
e resistere di fronte al fuoco di sbarramento degli archibugi.
Inoltre, i cannoni puntati contro i reparti di cavalleria alla carica, aprivano spaventosi vuoti
nelle fila degli attaccanti, rendendo vano ogni loro tentativo di vittoria.
Anche i fanti, spesso chiusi in quadrati difensivi dai quali spuntavano minacciose alabarde
e picche di varia lunghezza, avevano finito col soccombere di fronte agli archibugieri
che da lontano, senza il minimo rischio, potevano colpire i nemici compatti ma isolati.
I duelli individuali tra cavalieri lasciarono il posto al tiro al bersaglio;
veniva meno l'eroismo che aveva fatto dei cavalieri dei veri e propri eroi di un'epoca.
Le loro corazze non fermavano i proiettili, i loro scudi erano inefficaci di fronte alla palla
del moschetto che frantumava prima il ferro e poi le ossa.
L'arma da fuoco individuale diffusa tra i fanti fu l'ultimo, decisivo colpo dato alla cavalleria.
Il numero dei combattenti e il volume di fuoco potevano essere il fattore decisivo
nel determinare l'esito delle battaglie, ovviamente a scapito
del valore e dell'eroismo dei singoli individui.
Cominciarono a divenire insostituibili gli eserciti numerosi, dotati di migliaia di uomini,
reclutati direttamente dai sovrani, gli unici, che, appunto,
potevano sostenere le spese per una tale organizzazione.
I campi di battaglia, dopo l'introduzione delle armi da fuoco diventarono luoghi ove cimentare
la scienza della fusione dei metalli e la sperimentazione di macchine sempre più distruttive.

Prima della formazione degli eserciti nazionali,
la vita militare era nelle mani dei capitani di ventura
cioè dei condottieri degli eserciti mercenari.
I condottieri migliori furono gli Italiani: appartenevano ad una corporazione
con proprie regole e furono veri e propri professionisti della guerra.
Essi comandavano un gruppo di soldati che nei combattimenti si aiutavano reciprocamente
per cui si chiamavano compagni e «compagnia» fu chiamato l’esercito da loro composto.
Ma cosa significava “ventura”?
La parola, che deriva dal latino, indica “le cose che verranno”, dunque la sorte ed il destino.
Le compagnie di ventura erano in effetti composte da uomini che sceglievano
di partire in cerca di “fortuna”, di gloria, ma anche e soprattutto ricchezze.
Il fenomeno delle compagnie di ventura si sviluppò in particolare dopo le Crociate,
quando cadetti di nobili famiglie vennero avviati al mestiere ecclesiastico o delle armi.
Coloro che intrapresero la vita militare, penalizzati dalla primogenitura,
si organizzarono, mettendo la propria abilità nella armi a disposizione dei vari signori
che avevano necessità di difesa o di intraprendere campagne militari.
La prima compagnia italiana fu la Società di san Giorgio,
fondata nel 1376 da Alberico di Barbiano.

Nel XV° secolo furono numerosi i capitani di ventura italiani, chiamati condottieri
dal nome del contratto, la condotta appunto, che stipulavano col committente.
I più famosi furono Facino Cane, Francesco di Bussone detto il Carmagnola,
Muzio Attendolo Sforza, Erasmo da Narni detto il Gattamelata,
Bartolomeo Colleoni, Niccolò Fortebraccio, Giovanni de' Medici dalle Bande Nere.
Alcuni riuscirono a diventare signori: Francesco Sforza divenne signore di Milano,
suo fratello Alessandro di Pesaro, Braccio da Montone di Perugia, Niccolò Piccinino di Bologna.
Le compagnie più importanti arrivarono a contare fino a 10.000 soldati,
assunti a tempo determinato dai capitani.
In battaglia, i nemici erano fatti prigionieri invece che uccisi,
per poter ottenere il pagamento di un riscatto.
In tempo di pace le compagnie si mantenevano con saccheggi, minacce,
taglieggiamenti e ricatti, per cui erano molto temute dalle popolazioni.
I
Capitani di Ventura divennero marginali solo a fine ‘400, quando le nuove invasioni,
l’utilizzo di nuove armi e il consolidamento degli Stati Nazionali,
mutarono l’organizzazione militare.
Essi si trasformarono in generali al servizio di potenze straniere,
poiché ogni Stato si dotò di eserciti di bandiera.
Ma forse una delle cause più importanti della fine dello strapotere
delle compagnie di ventura in Italia, fu il declino della cavalleria pesante.
Uno degli ultimi condottieri fu Ludovico di Giovanni de’ Medici,
detto Giovanni dalle Bande Nere .

Giovanni dalle bande Nere fu ritenuto da Niccolò Machiavelli, l'unico capace
di difendere gli stati italiani dalla discesa di Carlo V.
Era figlio di Caterina Sforza e Giovanni dei Medici e aveva passato la propria infanzia
in un convento, poiché la madre era prigioniera di Cesare Borgia.
Nel 1509 quando Caterina Sforza morì,
la sua tutela passò al ricchissimo fiorentino Jacopo Salviati,
marito di Lucrezia de' Medici, figlia di Lorenzo il Magnifico.
Giovanni, che sin dall’infanzia aveva dimostrato un temperamento violento
e insofferente all’autorità, solo in parte frenato dalla forte figura materna,
divenne un adolescente rissoso e dissoluto, amante delle armi, del gioco e delle donne,
costretto per lunghi periodi lontano da Firenze nelle sue proprietà di Castello
di Trebbio proprio a causa delle sue violente intemperanze.
Sposò la figlia di Iacopo Salviati da cui ebbe Cosimo, il futuro granduca.
Diventato capitano di ventura, organizzò le sue famose Bande Nere,
il cui nome deriva dal colore delle bandiere che, da bianco e violetto
furono cambiate in nero in segno di lutto per la morte dello zio, papa Leone X.

Durante le guerre i soldati di Giovanni erano abilissimi nella tecnica dello
“sciame d’api contro l’orso”, ovvero si trattava di colpire con velocità il nemico in marcia,
spesso molto più grande in numero, per poi ritirarsi lesti.
Una tecnica di guerriglia che era raffinata perché si attaccava di giorno e di notte,
con rapidità, retrovie, depositi, reggimenti isolati, prima che gli avversari
potessero capire cosa succedeva e organizzarsi in una battaglia campale tradizionale.
A servizio ora del pontefice, ora dei Francesi, nella guerra della Lega di Cognac
fronteggiò validamente a capo della fanteria italiana, i lanzichenecchi imperiali,
stringendoli tra il Po e le paludi di Mantova; ma ferito a morte da un colpo di falconetto
dal duca di Ferrara, il 25 novembre 1526, morì tre giorni dopo a Mantova, in casa di Luigi Gonzaga,
nonostante l'amputazione della gamba per fermare la cancrena.
Moriva il soldato forse più amato dagli uomini in armi come lui e l'uomo sicuramente più odiato
dalla propria famiglia, in quanto gli altri Medici lo temevano.
Anche per questo forse, nonostante le insistenze degli stessi Guicciardini e Machiavelli,
Giovanni delle Bande Nere non venne mai messo a capo di un'armata che riunisse
tutte le truppe pontificie, ma quest'ultime furono suddivise tra vari inetti.
Lo piansero l'amico scrittore Pietro Aretino, il Duca d'Urbino e tutti i capitani confederati
(così Guicciardini definiva i "leghisti").
Morto lui, si bloccava anche quella manovra che l'Urbino aveva programmato con lo stesso Medici
allo scopo di fermare i Lanzichenecchi, che così trovarono aperta la via per Roma
ed il suo terribile sacco del maggio 1527, responsabilità primaria del quale é da imputare
proprio a Clemente VII, uomo vile e incapace, tipico prodotto della politica fiorentina dell'epoca.

Il primo esempio di esercito nazionale si ebbe nel sec. XV quando il re di Francia
Carlo VII volle, accanto alle superstiti milizie feudali, reparti di cittadini
L'avvento delle armi da fuoco fece sorgere la nuova specialità delle artiglierie
e gli eserciti si avviarono così ad assumere una fisionomia moderna
con la classica ripartizione nelle tre armi (cavalleria, fanteria e artiglieria).
Per molto tempo l'esercito spagnolo fu quello più regolarmente organizzato,
con precise norme organiche, disciplinari, amministrative, mentre in Italia
le prime milizie nazionali sorsero in Piemonte con il duca Emanuele Filiberto di Savoia.

In questo periodo non possiamo non ricordare, anche in Italia,
donne impegnate in azioni militari, soprattutto difensive.
Un primo esempio lo abbiamo già nel 1300 con Marzia degli Ubaldini da Susinana,
anche conosciuta come Cia degli Ordelaffi.
Un secondo caso, un po’ più tardo, è rappresentato da Orsina Visconti,
signora del feudo emiliano di Guastalla che,
nel 1426, nel corso delle guerre che opposero Milano e Venezia,
quando il suo feudo fu attaccato dalle truppe veneziane,
mentre il marito, Guido Torelli, era assente,
impegnato in altre campagne militari nel sud della Penisola,
difese la sua comunità con coraggio ed intraprendenza.
Orsina, invece che spaventata pare che si fosse sentita a suo agio nella battaglia.
Ella viene infatti descritta come «molto coraggiosa,
e nel mestiero delle armi grandemente addestrata» (Affò, p. 27).
Orsina diresse personalmente gli uomini in battaglia per spezzare
l’assedio veneziano,interamente armata e a cavallo.
La storia ci dice anche che, prima del combattimento,
ella andò sulle mura della città per insultare i soldati avversari, uccidendone diversi.
«La donna forte di quanto succedeva, e veduta l’occasione di far prova del suo valore,
chiamò tosto da Parma assai fanti, e balestrati, de’ quali fattasi condottiera ella stessa,
venne ad insultar quelle schiere che alla sua Guastalla strage minacciavano e ruina.
Fu bello il vederla di lucid’armi coperta frenar generoso destriero, disporre i suoi seguaci
a battaglia, ed esortarli con acconcie parole alla pugna; ma fu terribile ancora
il rimirarla scagliarsi addosso alle ostili squadre, sbaragliarle, e fugarle.
Lasciò ella morti più di cinquecento Schiavoni sul campo, varj de’ quali
caddero dal braccio di lei stessa trafitti: onde spaventato
il rimanente dell’esercito diedesi precipitosamente alla fuga. […]
La sua corazza poi colle altre armi da lei usate fu conservata come il più nobil trofeo
che adornar potesse l’Armeria delle Rocca» (Affò, pp. 28-30).

Un altro caso simile ci viene offerto qualche anno più tardi da una nipote di Orsina,
Donella Rossi-Sanvitale.
Nata nel 1435 fu la figlia di Pietro Maria Rossi, conte di Berceto e di Antonia Torelli,
a sua volta figlia di Guido Torelli e Orsina Visconti.
Nel 1448 anche Antonia diede prova di attitudine al comando e doti militari
aiutando suo marito a reprimere un sollevamento popolare nella città di Parma,
guidando una schiera di uomini armati, degna figlia della madre.
Quanto a Donella, ella sposò nel 1454 il conte Giberto Sanvitale, rivale di suo padre
nel quadro dell’aristocrazia parmense.
Il matrimonio, tuttavia, non riuscì a riconciliare le due fazioni e, nel 1482,
Donella si trovò sola a difendere il castello di Sala Baganza, uno dei più importanti
bastioni sanvitaleschi, dall’attacco di suo cugino, Amuratte Torelli.
L’assedio fu feroce, ma Donella seppe resistere, prendendo parte attiva
al combattimento, portando le armi ma anche motivando i suoi soldati
con incitazioni e incoraggiamenti.
«Tale oppugnazioni sostenevasi da Donella con fortezza
superiore ed animo di femmina, dando ella a dividere coraggio grande in quell’arduo cimento.
Assisteva armata ai difensori; e con virile costanza esortandoli, ammonendoli,
amichevolmente chiamandoli, e scorrendo pei baloardi
ne cresceva il fervore» (Ronchini, p. 132).
L’assedio si concluse non solo favorevolmente per Donella, ma essa riuscì anche a uccidere
il capo degli assedianti, Amuratte, con un colpo di archibugio tirato
dalle mura del castello che colpì il cugino al femore.
Ancora nel 1527, nel corso delle Guerre d’Italia, troviamo altri esempi di donne
alla difesa della comunità o del castello in assenza dei mariti.
In quest’anno, nella piccola comunità di Novellara, nella diocesi di Reggio Emilia,
Costanza da Correggio, moglie di Alessandro I Gonzaga, difese la Rocca di Novellara
e resistette all’assedio delle truppe veneziane e imperiali con
«animo d’homo, et non di donna» (Ariosi, p. 100).
Non possiamo non menzionare inoltre, Bianca Maria Visconti,
moglie di Francesco Sforza, che nel 1448 difese la città di Cremona dall’assalto
veneziano, guidando le truppe cittadine vestita di armatura.
Bianca Maria, divenuta duchessa di Milano, fu a sua volta responsabile dell’educazione
della più celebre donna in armi del Rinascimento italiano: Caterina Sforza.

Caterina Sforza nacque nell'anno 1463 a Milano, figlia di Lucrezia Landriani,
amante del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e moglie del cortigiano Gian Piero Landriani.
Gli storici la ricordano talvolta con il soprannome di la tigre di Forlì per la sua storica difesa della città.
Sin da giovane mise in mostra un carattere nettamente energico.
Fu signora di Imola e contessa di Forlì con il marito Girolamo Riario,
Morto il marito, ucciso da una congiura organizzata dalla famiglia forlivese degli Orsi,
che prese in ostaggio i suoi figli, si rinchiuse entro le mura della rocca di Ravaldino.

Si racconta che Caterina, stando sulle mura della Rocca, avrebbe risposto
a chi minacciava di uccidere i suoi figli, sollevandosi le gonne e mostrando con la mano il pube:
"Fatelo, se volete: impiccateli pure davanti a me. Qui ho quanto basta per farne altri!".
Gli Orsi non osarono toccare i giovani della famiglia Riario e la loro coraggiosa madre
e aiutata dallo zio Ludovico il Moro, Caterina riconquistò la signoria di Forlì,
che mantenne come reggente prima di consegnarla al figlio Ottaviano.
La vita di Caterina Sforza fu una sfida continua, per una donna forte in un mondo di uomini.
Ebbe un secondo marito, Giacomo Feo, di cui fu molto innamorata e un terzo ancora,
Giovanni de' Medici che le diede un figlio, Ludovico, che da adulto
sarà famoso con il nome di Giovanni dalle Bande Nere.
Giovanni de' Medici, detto il Popolano, era giunto alla corte di Caterina,
nel 1496 in qualità di ambasciatore della Repubblica di Firenze.
Le nozze, contrastate in un primo momento dallo zio di Caterina, Ludovico Sforza,
avevano infine ricevuto la sua approvazione e quella dei figli.
Dopo la nascita del piccolo Ludovico, Caterina dovette fare i conti
con il peggioramento della situazione tra Venezia e Firenze, dal momento
che i territori su cui governava erano sulle vie di passaggio dei due eserciti.
Improvvisamente Giovanni de' Medici si ammalò così gravemente che,
nonostante le cure, continuò a peggiorare e il 14 settembre del 1498
morì fra le braccia di Caterina che lo vegliò nelle sue ultime ore di vita.
Subito dopo la morte dell'amato Giovanni, Caterina tornò a Forlì
per occuparsi della difesa dei suoi Stati.
Fu lei a dirigere le manovre militari, a gestire l'approvvigionamento
dei soldati, delle armi e dei cavalli ed addestrare le milizie.
Per reperire denaro e rinforzi, non si stancò di scrivere allo zio Ludovico,
alla Repubblica di Firenze e agli Stati alleati confinanti.
Ma solamente il Duca di Milano e quello di Mantova inviano un piccolo contingente di soldati.
Un primo attacco dell'esercito di Venezia inflisse gravi danni nei territori occupati da Caterina.
Ma l'esercito di Caterina riuscì comunque ad avere la meglio sui veneziani.
Tra questi vi erano anche Antonio Ordelaffi e Taddeo Manfredi, discendenti delle casate
che avevano governato rispettivamente Forlì e Imola prima dei Riario.
La guerra però continuò con piccole battaglie, fino a quando i veneziani
riuscirono ad aggirare Forlì e raggiungere Firenze da un'altra via.
Ma Papa Alessandro VI si alleò il Re di Francia per avere il suo appoggio
nella costituzione di un Regno per il figlio Cesare Borgia nelle terra della Romagna,
e con una bolla pontificia fece decadere le investiture
di tutti i feudatari di quelle terre, compresa Caterina Sforza.
Caterina nel contrastare l'esercito del duca Valentino (Cesare Borgia) si trovò sola.
Arruolò e addestrò quanti più soldati poteva, immagazzina armi, munizioni e viveri.
Fece rinforzare le difese delle sue fortezze con opere importanti, soprattutto
quella di Ravaldino,
la sua residenza, già considerata inespugnabile.
Fece anche partire i figli perché fossero al sicuro a Firenze.
Cercò di resistere il più possibile ai bombardamenti del Valentimo e del re di Francia.
Le forze di Caterina inflissero numerose perdite all'esercito francese.
Ciò che i francesi distruggevano di giorno, veniva ricostruito durante la notte.
La notizia della resistenza solitaria di Caterina circolò in tutta l'Italia,
destando grande ammirazione.
Tuttavia non riuscì ad evitare la disfatta e fu costretta a piegarsi
davanti alla furia conquistatrice di Cesare Borgia, che dopo averle tolto
– non senza fatica – Imola e Forlì, la imprigionò proprio a Castel Sant’Angelo,
nella fortezza da lei conquistata anni prima con tanto valore.

Alla morte del Papa Alessandro VI, Caterina Sforza non riuscì a recuperare i suoi domini,
e trascorse a Firenze il resto della sua vita con i figli, scrivendo
dei suoi esperimenti alchemici e di alcune sue ricette di bellezza.
La “Tigre di Forlì”, che solo il più forte degli eserciti riuscì a piegare,
si spense il 28 maggio del 1509 a Firenze a 46 anni, stroncata da una polmonite.